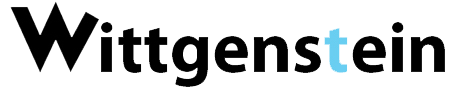Un amico giovane mi ha fatto una ragionevole domanda, dopo aver letto il mio post di ieri sui ricordi miei e di Michele Masneri (Masneri che, a suo credito, ha nove anni meno di me) rispetto ai “programmi di Pippo Baudo”. Mi ha chiesto: «ma se piuttosto che guardare i sanremo di pippo baudo era meglio farsi di eroina, chi li guardava?».
E dopo avergli risposto – ora ci arrivo – ho continuato a pensarci, e mi sono convinto che non abbiamo più abbastanza presente, e non lo trasmettiamo adeguatamente, cosa fosse il mondo prima dei social network, malgrado tutte le cose che ci ripetiamo. Certo, ci diciamo continuamente e pigramente – tra uno scrollare di TikTok e una storia su Instagram – quanto i social network abbiano peggiorato tutti: questo è facile e ormai automatico, signora mia. Ma forse perdiamo un po’ di vista le dimensioni del cambiamento, e quanto l’uso di smartphone e social network abbia proprio cambiato le vite, l’impiego del tempo, le relazioni col mondo intorno, a prescindere dai giudizi che ne diamo.
Allora, miei piccoli lettori, dirò intanto com’era il rapporto con “i programmi di Pippo Baudo” di noi adolescenti e ventenni negli anni Ottanta, per esempio. Di una parte di noi, di cui mi nomino rappresentante, ma sapendo che ce n’erano molte altre, come sempre e come oggi.
Intanto, Sanremo fa un po’ storia a parte (infatti Masneri quella battuta sull’eroina l’ha fatta non a proposito di Sanremo). Diciamo che Fantastico e Domenica In proprio non li guardavamo. Per fortuna erano in tv solo una volta a settimana, e il secondo di pomeriggio, quando difficilmente stavamo in casa. Di Fantastico poteva capitare che vedessimo i primi minuti, trovandoci a cena con la tv accesa e un’offerta limitata di programmi, prima di alzarci da tavola e probabilmente uscire coi nostri coetanei, o andarcene a farci fatti nostri in camera, senza social network e senza smartphone (e cosa facevamo? Telefonate, libri, guardare il soffitto, studiare in ritardo, embrioni di videogiochi, guardare il soffitto). Per Sanremo (che, ricordo, è un programma che occupa 5 sere su 365: non così presente nelle vite, assai meno di Happy Days, di Blob o di Discoring; o di Drive In, nel peggiore dei casi) era un po’ la stessa cosa, anche se la sorpresa delle canzoni aveva una qualche divertita attrattiva. Ma nessuno che lo avesse guardato tra di noi si sarebbe poi ricordato di cosa succedesse tra una canzone e l’altra: la sola cosa che ancora si cita di quei Sanremo sono alcune canzoni, non il programma tv, e in modo totalmente indistinto tra un’edizione e l’altra, che la presentasse Baudo o qualcun altro. Non è mai stata registrata come “tv”, ma solo come “canzoni”. E l’attrattiva maggiore era creata dagli ospiti stranieri, come nella leggendaria edizione del 1987.
Ma tornando al repertorio generale di “varietà televisivi”, erano programmi che invece guardava tantissima gente, e soprattutto per una ragione: non c’era internet, non c’erano gli smartphone, non c’erano i social network, non c’era Netflix. Nel 1987 a guardare la tv la sera di Sanremo c’era il doppio di persone rispetto al 2021 e quasi un terzo di persone in più rispetto al 2025 (che è andato meglio). Tanta gente, tante persone, guardavano la tv e guardavano la Rai (e tante guardavano Raiuno, anche perché la copertura degli altri canali era assai più limitata): è per questo che in quei programmi sono passati sempre ospiti importanti e famosi. E tante persone guardavano quel che c’era. Non tutte, però, solo una piccola parte della popolazione: anche allora c’erano quindici milioni di italiani che guardavano la serata finale di Sanremo e quaranta milioni di italiani che non la guardavano; e più di cinquanta milioni che non guardavano Domenica In e Fantastico: e chissà dove sono, oggi, che tutti sembrano ricordare Domenica In e Fantastico (li ricordano senza averli mai guardati, probabilmente: confermando che tutto quello che stiamo leggendo sia nostalgia della propria giovinezza, non di Pippo Baudo).
E in sintesi la risposta alla domanda del mio amico è, quindi: “il pubblico di quei programmi era un pubblico di persone che non aveva di meglio da fare, sia per proprie possibilità e curiosità sia per limitatezza dell’offerta”.
(“nazional popolare”, come venne definito quel tipo di programmi, aveva un’accezione diminutiva, di qualcosa di facile e di bassa qualità: era prima che si decidesse che il rispetto per il popolo non passasse dall’arricchirlo ma dal convincerci che la povertà è bella)
Ma c’è un altro pezzo di cambiamento da avere presente, sempre a proposito di quella domanda. Ed è che il pubblico di programmi come Sanremo (o come Temptation Island, versione contemporanea e aggiornata della mediocrità televisiva e umana di certi programmi di allora) è in parte diventato anche un altro. E anche questo c’entra con i social network, e con l’appiattimento (ma anche la “democratizzazione”) della conversazione sui contenuti culturali. Perché negli anni Ottanta e Novanta non solo tantissime persone non guardavano Sanremo né Fantastico, ma nemmeno ne avrebbero saputo niente (al massimo chi aveva vinto) né ne avrebbero voluto sapere: la separazione delle offerte e delle curiosità culturali era assai più rigida e deliberata. Non guardare Sanremo era come non conoscere gli Smiths (che andarono a Sanremo, quella volta del 1987): cose di cui poteva non fregartene niente, e bene così. Non avevi l’impressione (ingannevole) che tutti intorno a te parlassero di quello. Che era naturalmente un limite, nella conoscenza e comprensione di fenomeni (io non ho capito per anni cosa fosse l’esclamazione “has fidanken” di molti miei amici): ma questo è un limite che si mantiene ancora oggi – malgrado la maggiore contiguità delle bolle – per via della moltiplicazione delle bolle (io e decine di milioni di italiani non sappiamo niente neanche del Sanremo di questi anni). Ma permetteva anche di conservare una gerarchia di qualità tra le diverse offerte e di averla presente: che non era bacchettonismo o snobismo (non guardavamo Fantastico ma siamo capaci ancora oggi di citare tutto Vacanze di Natale, il primo), era la consapevolezza – tra tutte le cose che guardavamo – di cosa fosse di valore e di cosa fosse solo divertente e non riprovevole. Cosa ci migliorasse, cosa ci divertisse, cosa ci peggiorasse. Non eravamo più “colti” di oggi, per capirsi: ma era condivisa un’idea che determinati prodotti e attività culturali avessero un valore maggiore di altri, nel miglioramento delle persone, della convivenza e del mondo. Poi si poteva fregarsene, ma con un latente senso di inferiorità delle proprie ambizioni e interessi.
I social network e in generale il prevalere delle misurazioni quantitative della qualità – assieme all’avvento populista della difesa dei gusti delle maggioranze, qualunque siano – hanno annullato queste distinzioni: e hanno offerto una legittimazione a una serie di prodotti culturali che nel Novecento sarebbero stati schifati da una parte più selettiva del pubblico, consentendo a quel tipo di pubblico, oggi, di esibire quelli che oggi chiameremmo “guilty pleasure” non più come tali, con senso della misura e consapevole imbarazzo, ma invece come fiere rivendicazioni vanitose. E di liberare tutti da quel fastidioso senso di inferiorità dei propri interessi e delle proprie ambizioni. Guardare le stronzate ce lo raccontiamo persino come nobilitante, che siano in tv o su TikTok o altrove, perché “ne parlano tutti” e perché “è il paese reale”, e perché ci consente di conservare quel confortevole infantilismo anche nell’età adulta. Si porta, e non è più socialmente giudicato. E quindi guardiamo Sanremo e Temptation Island con la sopravvalutazione necessaria a parlarne poi serenamente sui social network, a sentirci aggiornati, a darci un ruolo e un’identità, in tempi in cui il morettiano “mi si nota di più se non vengo” non ha più nessun senso: perché se non vieni non lo nota nessuno.
E quindi la risposta sintetica alla domanda dovrebbe essere, deludente: “Era proprio tutto diverso”.