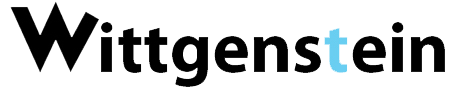Ovvero di quello che ho scritto qui.
La tesi di partenza è giusta: discutiamo di “intelligenza artificiale” con parole imprecise e spesso intercambiabili, e questo guasta la comprensione. Chiamarla semplicemente “AI” mescola software deterministici, modelli che generano testo e immagini, e sistemi che combinano più strumenti in catena. Pensarla come “strumento” più che come “agente” aiuta: riduce l’antropomorfismo, rimette al centro la responsabilità umana sul risultato, e abbassa il volume del panico morale. Ma conviene aggiungere un pezzo: gli strumenti di oggi hanno proprietà nuove — scala, apprendimento continuo, trasferibilità tra compiti, capacità di comporre funzioni diverse — che non erano presenti nei correttori ortografici o in Photoshop. Non basta dire “è solo software”: è uno software che, per come è costruito e addestrato, consente conseguenze diverse.
Nel quotidiano visibile, è vero, molti esempi sono miglioramenti di cose note: immagini rifinite, testi più rapidi da produrre, ricerca più comoda. Altrove però l’impatto è più sostanziale: progettazione assistita, analisi su grandi archivi, traduzione robusta, coding accelerato. Vale la pena dirlo esplicitamente per evitare il paradosso opposto: sottostimare proprio quello che stai denunciando come sovrastimato. È utile anche una piccola tassonomia operativa, non per la gioia dei classificatori ma per parlare chiaro: software deterministico; machine learning “classico”; modelli generativi (LLM, diffusione); sistemi agentici che usano strumenti. Non è una definizione definitiva, ma riduce l’ambiguità che critichi.
Sul tema della trasparenza: “conta il risultato” è un criterio pragmatico, ma non sempre sufficiente. In giornalismo, ricerca e PA, la provenienza è parte del valore: serve a verificare, attribuire, correggere, rispettare diritti. Una via ragionevole è la trasparenza “a soglia di materialità”: si dichiara l’uso quando l’AI contribuisce in modo sostanziale al contenuto o alla verifica; non quando è un ausilio minimale, come un correttore o una ricerca generica. Aiuta la fiducia senza trasformare ogni pezzo in una nota metodologica.
Lo scetticismo verso le separazioni nette resta sensato: non esistono prodotti “dell’AI” in senso magico, esistono prodotti di persone che usano strumenti. Ma proprio per questo serve qualche regola di officina: log di prompt e fonti quando l’AI incide davvero; revisione umana prima della pubblicazione; limiti d’uso su contenuti sensibili; metriche di qualità che misurino non la “novità” del mezzo, ma accuratezza, copertura, errori evitati. Così si tiene insieme ciò che conta: meno retorica sull’eccezionalità, più precisione linguistica, responsabilità chiarita, e disclosure dove pesa davvero. Il dibattito smette di galleggiare sulle parole e torna alle pratiche: di cosa stiamo parlando, che cosa fa, chi se ne assume la responsabilità.