Ok, oggi a Condor abbiamo parlato dei lupini dei Malavoglia. Alcuni di voi diranno “e che c’era da dire?”, altri diranno “ancora?”. Metto per iscritto qui tutto quello che ho imparato, sperando di rispondere alle due suddette interrogazioni.
Come ricorderete, è centrale nei Malavoglia il fallimento di un “negozio di lupini”, nel senso del commercio dei suddetti:
Padron ‘Ntoni adunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo zio Crocifisso Campana di legno un negozio di certi lupini da comprare a credenza per venderli a Riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c’era un bastimento di Trieste a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po’ avariati; ma non ce n’erano altri a Trezza, e quel furbaccio di Campana di legno sapea pure che la Provvidenza se la mangiava inutilmente il sole e l’acqua, dov’era ammarrata sotto il lavatoio, senza far nulla;
A scuola, quando si studiava e si leggeva I Malavoglia, nessuno aveva mai il coraggio di chiedere cosa fossero, ‘sti lupini. O alcuni lo davano per scontato, come gli stessi professori a cui non era mai stato detto né insegnato, ma seguivano la loro conoscenza della lingua. E così, in gran parte del paese si riteneva ovvio che si trattasse di quei legumi gialli che si consumano alle sagre (dalle parti mie, assieme alle seme), o alle partite di calcio, e vengono tenuti a mollo in secchi d’acqua dal venditore.
Ma in altre parti del paese, al nome di lupini corrispondevano certe specie di vongole, molluschi (Dosinia lupinus). E quindi tali venivano ritenuti i lupini della Provvidenza.
 A questo punto starete già tutti ridendo, ognuno della versione che ritiene errata, certo di aver sempre saputo cosa fossero, i lupini. Salvo quelli, e si è scoperto che c’erano, che si erano immaginati piccoli cuccioli di lupo. Ipotesi suggestiva, ma diciamo più improbabile (c’è anche una minoranza che li immagina pesci, e persino i casi di fucili “tipo lupare”, e un “maglioncini a lupetto”).
A questo punto starete già tutti ridendo, ognuno della versione che ritiene errata, certo di aver sempre saputo cosa fossero, i lupini. Salvo quelli, e si è scoperto che c’erano, che si erano immaginati piccoli cuccioli di lupo. Ipotesi suggestiva, ma diciamo più improbabile (c’è anche una minoranza che li immagina pesci, e persino i casi di fucili “tipo lupare”, e un “maglioncini a lupetto”).
Andiamo avanti. A un certo punto, le due ipotesi si sono scontrate, per qualche accidentale conversazione dedicata ai ricordi di scuola, o va’ a sapere. E internet ha poi esaltato questi confronti. Si trovano in diversi luoghi del web accese discussioni sul tema, e Akille sul suo blog ne ha ospitate ancora di recente.
Dalla parte dei legumi, per così dire, stanno i seguenti elementi: maggior quantità di sostenitori (si vedano anche i commenti alla puntata di oggi a Condor: se ci sommate le mail arrivate il rapporto è di circa due a uno), e implausibilità del fatto che dei molluschi possano essere “fradici” (e però qualcuno lo sostiene sinonimo di “marci”, indipendente dall’accezione liquida).
(Quel disgraziato di Verga per tutto il libro non ci dice mai niente di questi dannati lupini, se non che fossero “avariati” e “fradici”).
Dalla parte dei molluschi sta, mi pare, un solo elemento: che sia più realistico che una barca carichi delle vongole piuttosto che dei legumi (e però Verga spiega che erano caricati solo per trasportarli da un posto all’altro, non “pescati” o raccolti in mare). Se non vogliamo metterci anche la lectio difficilior.
Il risultato, a mio giudizio, è che dentro il libro non esistano elementi che definiscono esattamente cosa siano, i lupini in questione. E questo mi pare già notevole, indipendentemente dalla maggior plausibilità, a conti fatti, della tesi legume.
L’altra cosa notevole, culturalmente, è che su uno dei caposaldi tradizionali della nostra cultura scolastica e della nostra tradizione letteraria, tutti (compreso il corpo insegnante nella sua totalità, stando a una mia indagine sommaria) siamo sempre stati solidamente convinti di una cosa che invece è – come detto – quantomeno misteriosa e controversa, oppure non abbiamo mai capito di cosa si parlasse. Insegnanti avvisati, ma non so se con la Gelmini si facciano ancora i Malavoglia

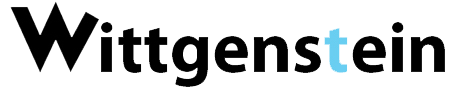

Pingback: Akille.net » Blog Archive » Il codice Verga