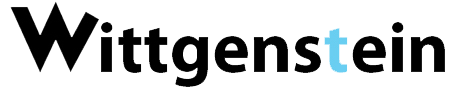Da quando il Post esiste, e si è incuriosito un po’ a tutto e alla comprensione di tutto, abbiamo dedicato le nostre maggiori attenzioni sui libri “ai contenitori piuttosto che ai contenuti”, come dicemmo poi spesso. Un po’ perché non lo faceva quasi mai nessuno, fuori degli ambiti degli esperti e dei professionisti, e un po’ perché “i libri” – i contenuti – sono una materia così varia da rendere irragionevoli molte sintesi che li riguardano. Mentre i modi in cui i libri – i contenitori – vengono progettati, prodotti, promossi, distribuiti, venduti, hanno molto di comune che spesso spiega molto meglio come un libro diventi o no un successo, una notizia, un pezzo della conoscenza condivisa.
Quindi abbiamo scritto spesso di questi meccanismi, abbiamo dedicato loro il primo numero di Cose spiegate bene, poi siamo diventati persino “editori” e questo ci ha aiutato a capirne di più, come quelle signore zoologhe e appassionate di gorilla che vanno a vivere tra i gorilla per studiarli meglio. E continuiamo a essere curiosi delle cose che i più esperti spiegano e raccontano, ospitandoli per esempio ai cicli di incontri online che organizziamo.
Nei giorni scorsi sulla Stampa sono usciti alcuni articoli interessanti, a partire da un primo di Loredana Lipperini su una questione che oppone i dipendenti delle librerie Feltrinelli all’azienda per cui lavorano. Nel frattempo sul Post stavamo spiegando una cosa che sta succedendo nelle librerie di catena, che è stata protagonista anche di quegli articoli sulla Stampa. E qualche settimana fa avevamo raccontato un po’ di numeri del mercato dei libri, che ai lettori raramente vengono citati, per mantenere il dibattito ancora un po’ concreto.
Quel dibattito sulla Stampa è proseguito ieri con una lettera pubblicata sul blog di Lipperini, ma il suo testo più interessante per noi lettori e curiosi era stata l’intervista al direttore editoriale dell’azienda editrice Neri Pozza, Giovanni Francesio, che uso assieme a quell’articolo sui dati di vendita per mettere in fila un po’ di cose che abbiamo imparato in questi anni sul mercato dei libri (quando diciamo “mercato dei libri” intendiamo i libri che le persone comprano e leggono, e le ragioni che permettono la sopravvivenza delle case editrici).
Uno. Francesio: «vendere libri è complicatissimo ed è esposto alla casualità molto più di quello che si pensa». Me lo ha detto un altro esperto editore poche settimane fa: «prima, non lo sa nessuno come andrà un libro».
Due. La grande maggioranza delle case editrici, quelle in una dimensione tra le piccolissime e amatoriali e i grandissimi marchi (ma vale un po’ anche per i grandissimi marchi), funziona sulla base di questo approccio: pubblicare ogni anno X libri sperando che il 95% di quei libri non faccia perdere troppi soldi e che il 5% sia invece un successo sufficiente a tenere in piedi tutto il bilancio.
E la ragione di pubblicarne il più possibile è quella che dice Francesio: che nessuno sa dove sia quel 5%. Sembra la famosa battuta sulla pubblicità: “nove su dieci dei libri che pubblico venderanno pochissimo, ma non so quali siano”. È un’economia basata su piccoli conti e prudenze, e su dita incrociate. Una specie di lotteria.
Tre. Il successo di un libro si misura sempre in termini relativi, rispetto alle aspettative e ai costi sostenuti (per pagare l’autore, per produrre l’oggetto, per il lavoro editoriale che ha impegnato, per l’investimento promozionale): quindi un libro che vende diecimila copie può essere per un editore molto più prezioso di uno che ne vende trentamila. Ancora Francesio: «Per mandare un libro in classifica, ne stampi almeno 15 mila copie. Se però il libro, per motivi imprevedibili, non vende, avrai migliaia di copie che restano invendute. In Italia c’è il 30 per cento di resi: è un numero enorme».
Quattro. Postilla decisiva al punto due: è un’economia basata anche su un’altra cosa: “il catalogo“. I bilanci di diverse case editrici sono salvati dai libri che continuano a vendere – anche numeri non enormi – nel corso del tempo, quando i costi di produzione iniziali si abbassano. Esempio massimo e attuale: le edizioni del Conte di Montecristo che sono nel catalogo di ogni editore, per cui non ci sono più diritti da pagare, e di cui esce una serie tv che porta clienti in libreria. Ma è solo un esempio passeggero: ci sono long seller molto più radicati che tengono in piedi le case editrici (che quindi non disperano mai che un libro andato dignitosamente all’uscita diventi un long seller).
Cinque. Come si capisce, è un’economia ancora basata su costi e impegni molto tradizionali e non intaccati dalle grandi trasformazioni digitali (l’unica, grande ma isolata, sovversione del sistema è stata Amazon): nella quale ci sono carta da acquistare, lavoro umano in grandi quantità, magazzini da gestire, prodotti da spostare in sedi disseminatissime, pile da esporre, sapienza ed esperienza antiche tuttora competitive e non azzerate dalle innovazioni, pressioni degli uffici stampa per una recensione (che a sua volta nella maggior parte dei casi farà vendere due copie in più).
Sei. Quando guardiamo i dati di vendita, capiamo che quello che costituisce la gran parte di ciò che gli italiani comprano (e forse leggono) è assai distante dall’idea più immediata di “libri” che abbiamo abitualmente. I libri degli “scrittori” sono pochi tra quelli che vendono di più, mentre ai primi posti alla fine dell’anno ci sono soprattutto: libri di celebrities o di autori con visibilità televisive, libri di genere “romance” o “fantasy” (o “romantasy”) che si costruiscono fedeli culti e i cui autori e autrici sono ignoti a quasi tutti fuori da quei culti, alcuni libri di fumetti (calati nell’ultimo anno), e la categoria che un po’ più si avvicina a un’intuitiva idea di “letteratura”, i gialli/polizieschi. I libri che concorrono ai premi, per dire, vendono molto poco (salvo quelli che poi vincono i pochi premi maggiori).
Sette. Meritano un punto sette i libri per bambini o per ragazzi, che costituiscono un capitale consistente e costante delle vendite di molte librerie e di alcuni editori. Non fanno notizia, non ne leggete negli inserti culturali, ignorate i nomi dei loro autori e autrici (che vendono decine di migliaia di copie, in alcuni casi), ma sono un pezzo rilevantissimo dei numeri di fine anno su “quanto leggono gli italiani”.
Otto. Questa si dice sempre, ma vale la pena descriverla meglio: si pubblicano troppi libri. Circa 80mila l’anno. Sappiate che i libri usciti nel 2024 che hanno venduto più di duemila copie sono circa tremila: gli altri settantasettemila ne hanno vendute meno (e la gran parte molto meno). Anche gli editori più famosi e importanti pubblicano ogni anno diversi libri che non raggiungono le mille copie vendute. Tutto per via di quel meccanismo “lotteria”. Che naturalmente si autoalimenta: più biglietti della lotteria circolano, più è difficile vincere la lotteria, più biglietti compri. Gli spazi sui banchi delle novità e nelle vetrine delle librerie sono fisicamente limitati, e così tutte le altre occasioni di visibilità delle nuove uscite, che quando non sembrano andare bene subito spariscono immediatamente, rimpiazzate dalle successive.
Nove. Ci sono modi per governare questi processi? In parte, e quasi tutti molto tradizionali: investimenti e potere di promozione aiutano. Gli editori che hanno loro librerie spingono i propri libri, gli editori più ricchi riescono a ottenere gli autori e le autrici che offrono il capitale della loro notorietà televisiva (soprattutto maschi: mi permetto di azzardare che i lettori e le lettrici che comprano i libri di giornalisti e personaggi televisivi hanno ancora un rapporto patriarcale con l’autorevolezza presunta), alcuni autori e autrici hanno saputo creare un nuovo tweak del sistema attraverso la creazione di community sui social network. Oggi è pratica frequente promuovere le prenotazioni (soprattutto su Amazon) del proprio libro all’interno di queste community, grandi e piccole, in modo da vendere molto immediatamente e sfruttare quell’istantaneo successo per garantirsi attenzioni nelle settimane successive (un libro che si chiama Onyx storm ha venduto l’impressionante cifra di 25mila copie nella settimana dell’uscita, a metà gennaio, e poi 15mila nelle otto settimane successive).
Un altro approccio condiviso dagli editori di ogni scala è investire sulla fedeltà della gran parte dei lettori ai propri gusti e alle proprie soddisfazioni: e quindi replicare scelte che hanno funzionato una volta, che si tratti di argomenti, personaggi, o persino titoli e copertine, con imitazioni più o meno riuscite.
Dieci. Lo so, gli esperti veri troveranno un sacco di mancanze e di eccezioni a questi appunti: siamo solo appassionati di gorilla mimetizzati nella giungla. Ma spero di avere condiviso delle cose un po’ ignote per voi là fuori, appassionati di documentari sui gorilla.