Mi commuovo sempre un po’ quando vedo le foto della mia città sui giornali. In questi giorni sull’Unità c’erano i lungarni di Pisa e Piazza dei Cavalieri, per via delle proteste universitarie. Posti fotografati e riprodotti in mille occasioni, belli come sono.
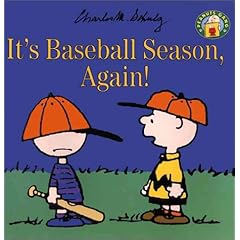 C’è un posto, a Pisa, che non vedrete mai in fotografia. È un posto insulso e anonimo alla periferia della città (la periferia, a Pisa, è a dieci minuti di cammino dal centro): una rotonda stradale circondata da sterpaglie, casette basse, e un cavalcavia di fronte. I pini di un viale le fanno ombra. Lì, in mezzo a quella rotonda, venticinque anni fa stava il nostro ricevitore.
C’è un posto, a Pisa, che non vedrete mai in fotografia. È un posto insulso e anonimo alla periferia della città (la periferia, a Pisa, è a dieci minuti di cammino dal centro): una rotonda stradale circondata da sterpaglie, casette basse, e un cavalcavia di fronte. I pini di un viale le fanno ombra. Lì, in mezzo a quella rotonda, venticinque anni fa stava il nostro ricevitore.
Quando sanno che segui il baseball, e che pure ti piace, in Italia ti guardano come se gli avessi detto che ti nutri solo di uova di quaglia. Non si capiscono le regole, e tutte quelle pause, è una roba da americani (metà delle nostre vite è una roba da americani, nel frattempo). E hai voglia a spiegargli la grandezza letteraria ed epica delle storie che stanno dentro a una partita di baseball, persino superiore a quella che trovi nel calcio, che pure è più avvincente. Alla fine io mi limito a dire: “no, è che giocavo, da ragazzo”. E allora vedo facce più sollevate, rassicurate, come avessero scoperto che non ho una malattia contagiosa ma una innocua malformazione dalla nascita: un po’ impietosite, persino. Possono cambiare argomento.
Il baseball in Italia ebbe una breve stagione di crescita, piccola piccola, concentrata soprattutto nei posti dove stavano gli americani – Livorno, Nettuno – o nell’Emilia dei sogni americani gucciniani. Anche a Pisa, come a Livorno, avevamo la base di Campo Darby vicina, e per qualche vicenda di cui dovrei tornare a farmi raccontare, un signore che noi ragazzi chiamavamo “il Professore” mise in piedi sia una squadra di ragazzi che una di ragazze (le ragazze giocavano a softball, la variante più soft, appunto, del baseball). Le ragazze andarono molto forti nel loro campionato, noialtri assai meno. Una specie di squadra dei Peanuts. Io poi ero una schiappa completa, avevo tredici anni e un fisico da tre anni meno. Quando non mi tenevano in panchina mi parcheggiavano in fondo al campo, esterno destro, ad aspettare palle che non arrivavano mai. Non credo di aver mai infilato una battuta in tutta la mia carriera. Mio fratello, schiappa quanto me ma mancino, otteneva rari momenti in prima base. Avevamo persino uno sponsor, la Tiglio, che faceva delle scarpe da tennis improbabilmente battezzate “Go-Scarpa”, e allora di qualche notorietà. Le tute arancioni.
 E avevamo un campo. Il Professore aveva conquistato non so come una piccola distesa di terra dove finiva la città, presa tra una discarica abusiva e un capannone industriale, e circondata da una fragile rete metallica. I fuoricampo, rari per noi, finivano nell’erba altissima o in un fosso. Lo spogliatoio era una baracca di lamiera ondulata. La domenica mattina i genitori venivano a vederci giocare arrampicati su una tribunetta di tubi Innocenti, o ci accompagnavano in trasferte che si spingevano ai quattro angoli della Toscana. Di solito perdevamo. Poi partecipammo a un torneo di respiro nazionale, che si svolse però molto vicino, a Tirrenia. Dei ragazzini di Alghero ci ammollarono una batosta impressionante, e quello segnò di fatto la fine della squadra. Probabilmente cominciavano a mancare voglia o soldi, ma a me nessuno lo spiegò. Ho il piccolo guantone dentro qualche soffitta.
E avevamo un campo. Il Professore aveva conquistato non so come una piccola distesa di terra dove finiva la città, presa tra una discarica abusiva e un capannone industriale, e circondata da una fragile rete metallica. I fuoricampo, rari per noi, finivano nell’erba altissima o in un fosso. Lo spogliatoio era una baracca di lamiera ondulata. La domenica mattina i genitori venivano a vederci giocare arrampicati su una tribunetta di tubi Innocenti, o ci accompagnavano in trasferte che si spingevano ai quattro angoli della Toscana. Di solito perdevamo. Poi partecipammo a un torneo di respiro nazionale, che si svolse però molto vicino, a Tirrenia. Dei ragazzini di Alghero ci ammollarono una batosta impressionante, e quello segnò di fatto la fine della squadra. Probabilmente cominciavano a mancare voglia o soldi, ma a me nessuno lo spiegò. Ho il piccolo guantone dentro qualche soffitta.
Il campo se ne andò in malora, anno dopo anno. Poi, una quindicina di anni fa, fu progettata una nuova viabilità in quella zona della città che oggi ospita il mercato bisettimanale, e sul mio posto di esterno destro venne costruita una strada. Al posto del campo, ora c’è questa rotonda. Ci ho pensato, quando un mese fa le due squadre di New York hanno abbandonato i loro storici stadi – lo Yankee Stadium e lo Shea Stadium – in mezzo a grandi cerimonie e commozioni.
Ieri notte ho fatto tardi: dopo due giorni di sospensione per pioggia i Phillies di Philadelphia hanno vinto le finali del baseball contro i Tampa Bay Rays, e sono campioni. È l’unica notizia che ha rubato la prima pagina alla campagna elettorale, in questi giorni. Ne scriveranno anche i giornali italiani, ma i lettori saranno pochi: non si capiscono le regole, e tutte quelle pause, troppo una roba da americani. Magari cerco su Facebook i miei compagni di squadra, domattina.


