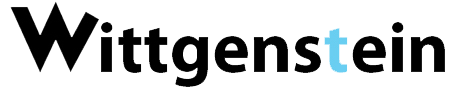Il problema è che non sappiamo di cosa parliamo quando parliamo di democrazia. Come con molte altre parole intorno a cui concentriamo pigramente riflessioni che dovrebbero essere più complesse e non limitarsi a slogan, finiamo per usarla per indicare troppe cose diverse, per dimenticarci dei “dipende”, per rinunciare a pensare alle eccezioni alle regole e alle regole sulle eccezioni.
Se la democrazia fosse solo la libertà delle persone di scegliere il proprio futuro attraverso dei rappresentanti che le persone eleggono liberamente, come la parola indica, sarebbe tutto più facile (chiamiamola “Democrazia facile”). Se questo fosse tutto quello che dobbiamo tutelare, la democrazia sarebbe un’idea perfetta e senza rischi o controindicazioni. Ma la storia lontana e recente conosce molti casi in cui questa applicazione della democrazia da sola ha generato mostri, dittature, pericoli per la democrazia stessa e persino abolizioni della democrazia.
E infatti, come sanno tutti, abbiamo accumulato un sacco di citazioni famose sui limiti e sulle imperfezioni della democrazia: e abbiamo accumulato quindi un sacco di regole accessorie che servono ad attenuare limiti, imperfezioni e rischi, e abbiamo convenuto che queste regole siano a loro volta parte della democrazia (chiamiamola “Democrazia complessa”). Per fare un esempio piccolo e concretissimo: alcune di queste regole concepiscono persino che ad alcuni cittadini sia tolto il diritto di votare, limitando così l’esercizio stesso della democrazia.
Il problema – un altro – è che tutte queste regole sono decise dalle istituzioni democratiche (i parlamenti, i referendum, i governi) e a partire quindi dal funzionamento della democrazia: ne sono quindi sia il risultato che il fattore. Vengono create da rappresentanti eletti democraticamente e stabiliscono come i rappresentanti vengono eletti, per esempio: sono regole che si autolegittimano. Putin potrebbe sostenere che la Russia sia una democrazia: le persone vanno a votare e c’è un sistema di regole creato dalle istituzioni di quel sistema. Qualunque decisione di Trump può ritenersi democratica: risulta da una libera elezione che si è svolta secondo le regole di una Democrazia complessa (almeno fino a che una corte non stabilisca che la decisione ne viola le regole, e protegga a sua volta il funzionamento democratico).
La ragione per cui la Russia non è una democrazia è che le regole di una democrazia devono essere scelte in un contesto che garantisca anche un alto grado di libertà, sia per gli elettori sia per i candidati che per i mezzi di informazione: è un altro elemento della Democrazia complessa. Questo possiamo facilmente dire che non esista in Russia, e possiamo facilmente dire che esista in Italia e in Francia e negli Stati Uniti, anche se nessun paese è perfetto in questo senso.
L’applicazione delle regole a tutela e protezione della democrazia è affidata – nei paesi democratici e liberi – soprattutto a quello che viene chiamato “uno dei tre poteri dello stato”, ovvero la magistratura. È un pezzo del funzionamento democratico. E qui arriva la contraddizione inevitabile che crea il problema iniziale, quello per cui ognuno parla della democrazia a modo suo, confondendo Democrazia facile e Democrazia complessa. Quando il potere giudiziario interviene per far funzionare la Democrazia complessa, applicando le regole che ne sono parte, le vittime di questi interventi si richiamano alla Democrazia facile: e dicono che il voto dei cittadini deve prevalere su tutto, e che le scelte della magistratura sono discutibili e sono “ingerenze”, anche perché provengono da un organismo non eletto, quindi estraneo alla Democrazia facile. Protestano insomma, perché la Democrazia complessa limita la Democrazia facile: e questo è vero, soltanto che il senso della Democrazia complessa è proprio limitare i difetti e le manchevolezze della Democrazia facile (quelli contenuti in tutte quelle citazioni di Churchill eccetera).
La magistratura è un potere che a sua volta obbedisce a molte regole condivise della Democrazia complessa, che però le lasciano un cospicuo margine di interpretazione, in qualunque ambito. E quindi è legittimo criticare le sue decisioni e considerare che, malgrado le regole, possano essere sbagliate: ma se si crede alla Democrazia complessa, bisogna tollerarle anche quando sono sbagliate. Non si può pretendere che le regole non siano applicate, perché quelle regole sono parte della democrazia. Al massimo si possono cambiare le regole (è quello che sta cercando di fare, democraticamente, l’attuale maggioranza di governo italiana).
Il problema, quello vero, con la democrazia, è che tutto questo rimane sempre imperfetto: la democrazia è piena di debolezze, che attenuiamo creandole altre debolezze, e continue contraddizioni. La Democrazia complessa si autolegittima: se il contesto ha una misura soddisfacente di libertà (che non è scontato nemmeno nei nostri paesi: prendete i rischi contemporanei alla libertà di informazione, ovvero a un’informazione accurata), qualunque cosa avvenga in un sistema democratico complesso è corretto.
Quello che potrebbe aiutare, un po’, è essere consapevoli di questo, ricordarsi le citazioni sui limiti della democrazia, e proteggere non solo la Democrazia facile ma anche la libertà e l’informazione accurata che sono un gran pezzo della Democrazia complessa. La libertà dei candidati di essere eletti ma anche la libertà degli elettori di non essere ingannati.
Se non altro per evitare discussioni stupide, ignoranti, sterili e ripetitive (che effetto vi fa il dibattito sulle ingerenze dei magistrati nella politica, nel 2025?), e farle diventare qualcosa di più evoluto, proficuo e consapevole delle complessità e delle imperfezioni della realtà.