1. Nel numero speciale del New York Times Magazine dedicato al cancro (molto bello, insegna e spiega tante cose con accuratezza scientifica e linguaggi per profani) c’è un articolo in particolare che vorrei mettere in relazione con altre riflessioni: spiega gli sviluppi nella ricerca sul cancro, e in particolare come si sia passati da un’idea “classificatrice” dei tipi di malattie a cui applicare cure standardizzate e universali – “protocolli” – a un approccio che considera ogni caso come peculiare e quasi unico per la complessità dei diversi aspetti e fattori che lo costituiscono. E racconta come il lavoro dei medici – di fronte a un male oggettivamente incomprensibile, e che i medici non comprendono più di tanto – sia oggi soprattutto di mescolare esperienza, letteratura esistente, e sperimentazione su ogni paziente, perché ogni malattia di ogni paziente reagisce diversamente a ogni cura (“L’oncologo improvvisatore” è il titolo dell’articolo), generata com’è da tantissimi fattori diversi e originali.
Increasingly, we are approaching each patient as a unique problem to solve. Toxic, indiscriminate, cell-killing drugs have given way to nimbler, finer-fingered molecules that can activate or deactivate complex pathways in cells, cut off growth factors, accelerate or decelerate the immune response or choke the supply of nutrients and oxygen. More and more, we must come up with ways to use drugs as precision tools to jam cogs and turn off selective switches in particular cancer cells. Trained to follow rules, oncologists are now being asked to reinvent them.
2. La settimana scorsa il Post ha tradotto un interessante articolo del Washington Post che spiegava come sia arbitraria e approssimativa la gran parte dei tentativi di previsione sui risultati futuri di mille questioni diverse: dai successi dei film, agli andamenti delle campagne elettorali, agli investimenti finanziari.
Ogni volta che proviamo a predire un risultato complesso, ci addentriamo in un campo minato (…) Cercare di valutare con precisione sistemi complessi influenzati da variabili casuali e correlate tra loro, da fattori esterni e dall’imprevedibilità del comportamento umano è una follia. Anche se non ci piace ammetterlo, nessuno sa niente, compresi noi.
3. Il mondo dei prodotti giornalistici è in crisi da diversi anni in tutto il mondo, e nello spaesamento si è affidato per molti anni (alcuni ancora ci si affidano adesso) all’idea speranzosa che ciò che internet aveva distrutto come modello di business sarebbe stato ricostruito in un altro modo: ovvero che una diversa maniera di ottenere dei ricavi dai contenuti giornalistici sarebbe saltata fuori. Che questa ricerca enorme, continua e globale avrebbe portato a una soluzione unica e generale che a un certo punto avrebbe salvato tutti, rimpiazzando il sistema economico che nei giornali tradizionali si basava sulle copie a pagamento e sui ricavi pubblicitari (ed è un approccio che è stato anche quello dei grandi investimenti di vent’anni fa su internet in generale, prima dello scoppio della “bolla”: tutti mettevano un sacco di soldi nella novità di internet, perché “torneranno, bisogna solo capire come: ma poi funzionerà per tutti”).
Quello che si è capito da un pezzo, invece, è che se alcuni business giornalistici ce la fanno (o ce la faranno), ce la fanno ognuno con una sua specificità, riuscendo a ripagarsi o a guadagnare con modelli diversi legati al tipo di prodotto, al contesto, al tipo di lettori, alle qualità del contenuto e ai suoi meccanismi di diffusione. E che quello che funziona per un sito di news qui, non funziona per un sito di news dieci chilometri più in là; e che se certi olandesi si sono inventati un’edicola online che pare funzionare, il risultato di quell’edicola online non si riesce però a riprodurlo in nessun altro posto del mondo, con progetti differenti.
4. Lo stesso giornalismo è, in ultima analisi, un lavoro di riconduzione a schemi semplificati di realtà che sono infinitamente complesse e ogni volta diverse: “protocolli”, a cui si applicano variazioni che sono una piccolissima frazione delle peculiarità reali di ogni storia e notizia.
5. Siamo nella metropolitana, tocchiamo un vetro con un dito dieci volte e riusciamo a parlare con uno dall’altra parte del mondo. E però cade la linea. Cosa è successo, ci chiediamo? Ma cosa era successo prima? Chiunque raggiunga una discreta familiarità con la tecnologia, con i suoi meccanismi, con le ragioni per cui gli apparecchi e i software funzionano come funzionano, soprattutto quelli digitali, a un certo punto assume anche un cospicuo grado di incomprensibilità delle cose: quando il computer non scarica tutte le mail, non è strano. Strano è che lo abbia fatto tutte le altre volte e che riprenderà a farlo tra poco (“Hai mai guardato dentro a un computer? Quello che è incredibile è che quella roba lì faccia le cose che fa, non che a volte non le faccia”, diceva il mio primo guru). Anche i maggiori esperti – nessuno escluso – a un certo punto ricorrono alle soluzioni più frequentate: spegni e riaccendi, chiudi e riapri, riavvia, riprova più tardi. Per scherzo la chiamiamo “magia”, o “mistero”, ma è anche questa una dimostrazione che la scienza è anche la conoscenza di non avere sempre le risposte.
Questi casi e questioni molto diversi tra loro hanno in comune alcune cose: raccontano che noi umani siamo umanamente inclini – bisognosi – a ricondurre la complessità e la diversità a un numero ridotto di schemi semplificati, a trovare delle regole e delle soluzioni universali, a mettere gli effetti in relazione a delle cause, ad abituarci a dinamiche ripetitive. È una comprensibile misura di sopravvivenza, una necessità di sapere che una soluzione non è effimera ma che una volta trovata sarà un investimento per il futuro: che quando una cosa accadrà, gli esiti saranno gli stessi che abbiamo già osservato e che quindi ora conosciamo. Naturalmente ci sono molti ambiti in cui questo avviene, fino a una certa misura – la conoscenza, la scienza, esistono: e la scienza è un misto di sapere e sapere di non sapere – e soprattutto sottrarsi a questo tipo di pensiero sarebbe paralizzante: viene da qui il luogo comune sulla “follia” legata alle grandi imprese, per compiere le quali bisogna rimuovere irrazionalmente la palese inafferrabilità delle cose. E infatti – come racconta il primo caso citato, quello degli oncologi – gli approcci più saggi e proficui sono quelli che mescolano una conoscenza dei precedenti, una consapevolezza delle unicità e della necessaria duttilità conseguente, e l’ottimismo della volontà, che è una specie di follia dettata dalla ricerca del bene, che tu sia oncologo o primo ministro.
Ma sto andando dietro a troppi pensieri e parentesi, era per appuntarmi poche cose che hanno troppe implicazioni per un post ordinato. Non so perché, poi: il mio editore mi diceva sempre (ormai ha rinunciato) di costruire un libro intorno intorno a un’idea semplice e valida sempre in contesti diversi, meccanismo che ha fatto il successo di tanti popolari saggi contemporanei. Ma se l’idea semplice è “nessuna idea semplice è valida sempre in contesti diversi”, temo non diventeremo ricchi. Quello che ottiene successo presso noi umani, è la semplificazione, la riduzione della complessità, le poche regole, le soluzioni. Una delle difficoltà maggiori degli oncologi coi pazienti ancora poco esperti, è far loro accettare la risposta “non possiamo saperlo”. Che è una delle difficoltà maggiori di chiunque ne sappia abbastanza di una cosa (la ragione per cui non mi invitano più ai convegni sul futuro del giornalismo: perché rispondo “non lo sa nessuno”).
Ed è anche il tema della politica, quella di “la gente vuole risposte chiare” e del successo sempre crescente dei politici che dicono cose semplici e assolute, definitive, che annunciano soluzioni, fanno promesse, mostrano certezze, a cui nessuna persona attenta e ragionevole potrebbe credere. Provateci voi, a farvi eleggere, dicendo “le cose sono complesse” e “bisognerà vedere caso per caso” o “non possiamo saperlo con esattezza”. Per questo la politica rende tutti bugiardi, inevitabilmente, perché la democrazia è stata progressivamente sostituita da un sistema di raccolta e conservazione del consenso, in cui nessuno si preoccupa se il paziente muore, e forse nemmeno il paziente stesso.
Ma sto andando da un’altra parte, o forse sto tornando su cose note. Volevo prendere un po’ di appunti.

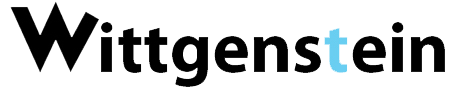

Bello l’articolo del NYT, davvero istruttivo. Mi fa anche ripensare un pochino a Di Bella e al fatto che forse l’abbiamo bollato come ciarlatano con un po’ troppa fretta.
Bello l’articolo di Sofri. A me ha fatto pensare alle prove INVALSI, che qualcuno vede come ‘oggettive’, o anche come ‘valutazione dell’operato degli insegnanti’.
Caro ulysses, ma è proprio lì il punto: dobbiamo costruire sulla sabbia come se fosse roccia.Gli Invalsi sono il meglio che al momento sappiamo fare. Gli Invalsi del 2116 saranno probabilmente molto meglio (ma ci sarà sempre qualcuno che mugugna che non vanno bene), ma ancora non li conosciamo e per arrivarci dobbiamo passare attraverso quelli di oggi. Se aspettiamo la roccia, perderemo anche la sabbia.
Negli anni ’80, il prof. Di Bella (che per primo trovò la cura per una forma di leucemia da cui oggi si guarisce) seguiva il modus operandi che tutta la ricerca oncologica contemporanea segue (“ogni caso come peculiare”) modulando la terapia con statine secondo le risposte biologiche del singolo paziente. La sua cura funzionava: pazienti con cancro continuavano a vivere bene (convivendo con la massa tumorale bloccata dalle statine) per oltre 30 anni dopo la diagnosi (30 anni!), conducendo una vita normale e facendo pure sport. Per questo la “terapia Di Bella” diventò nota: perché funzionava, generando il passaparola di chi veniva “guarito”. Il ministero guidato dalla Bindi cercò invece di dimostrare che il metodo Di Bella non funzionava e riuscì nell’intento perverso proprio applicandolo come un protocollo identico su tutti i pazienti. Ma questo non era più il “metodo Di Bella”, era esattamente l’errore metodologico che Di Bella aveva individuato e risolto. Il prof. Di Bella, può dirlo chiunque l’abbia conosciuto, non era un ciarlatano, ma un clinico esperto e molto competente (aveva tre lauree: medicina, ingegneria e fisica, e insegnava fisiologia umana all’università). Soprattutto: era una persona di un’umanità rara. Lo sciacallaggio mediatico che subì fu violenza turpe su un uomo buono.
Mettere in contrapposizione i protocolli standardizzati e l’attuale pratica clinica in oncologia e’ fuorviante, come lo e’ il titolo dell’articolo del NYT e dire che gli oncologi oggi devono reinventare le regole. Se e’ vero che malati con un certo tipo di tumore, per esempio AML, CML o linfoma, vengono trattati in maniera individualizzata, e’ anche vero che non c’e’ nessuna improvvisazione o sperimentazione. Vengono semplicemente scelte opzioni terapeutiche tra quelle che sono state approvate dalla comunita’ scientifica, in definitiva si seguono protocolli. E l’autore nella parte finale lo spiega bene: solo in alcuni pazienti di CML il farmaco Gleevec viene dato e funziona: c’e’ infatti un protocollo standardizzato che impone di darlo solo a pazienti che abbiano una mutazione nel gene BCR-Abl. A occhi esterni puo’ sembrare che l’oncologo dia trattamenti diversi a 10 pazienti di CML perche’ sta provando o sperimentando sui pazienti, ma in realta’ sta seguendo protocolli specifici per specifiche classi di pazienti.
Caro hermann mi pare che un punto di Sofri sia di stare attenti a convincersi che la sabbia è roccia.
Mi sembra che la semplicità nella politica,così come nel giornalismo (che di politica si occupa,ancora,in gran parte) sia un’esigenza improcastinabile.La discrasia,semmai,è data dal fatto che-dagli anni novanta,per la prima volta in modo così evidente-siamo di fronte a una società complessa(comunque più complessa delle altre,cosa acuitasi con crisi 2008).La tecnologia poi,per sua natura,deve semplificare,è ovvio.E sempre una maggiore semplificazione le si chiede.Proprio da domande/considerazioni tipo “la mail non è arrivata,che strano” partono i miglioramenti,le scoperte.La complessità non è il futuro, semmai,a dirla tutta,il futuro è la lotta alla complessità.Le cose arzigogolate e complicate lasciamole ai filosofi tedeschi dell’800,ben chiusi nei libri.Oppure a quel famoso aforisma di Flaiano.
Ulysses hai ragione, avevo letto il tuo post troppo affrettatamente.
Tradotto in politica
– smettiamola di credere che i nostri politici abbiano la bacchetta magica, non esistono soluzioni facili a problemi complessi ma solo soluzioni che comportano rinunce e sacrifici
– smettiamola di pretendere sempre “risposte immediate”. Le vere soluzioni comportano riflesisone, tempo per essere attuate, continuità di applicazione; spesso sono soluzioni impopolari
– diffidare di chi ti prospetta soluzioni facili o risposte immediate; nel 90 percento dei casi è un ciarlatano
– se dai credito a chi ti prospetta soluzioni facili un po’ ciarlatano lo sei pure tu
Pardon s’il vous plait per l’off topic.
Il mio piccolo ricordo di Marco.
http://bsidex.over-blog.com/2016/05/marco-pannella-un-gigante-tra-i-provinciali.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_twitter&utm_campaign=_ob_share_auto
Il mio piccolo ricordo di Marco
Ah ecco, mi pareva strano che non fosse ancora comparso quello che «sparite, plebèi, voi non avete diritto al cordoglio: io, invece… »
@SteveRomano fuori luogo il tuo commento;o non hai capito cosa ho scritto oppure hai la coda di paglia,o magari entrambe.Non serve aggiungere altro in questo momento di cordoglio..